Viaggio in Calabria. Terzo giorno di cammino.
Al mattino smontammo la tenda sotto lo sguardo incuriosito di qualche anziano mattutino, appostato come guardie sul lungomare. Nel bel mezzo delle operazioni sentii squillare il cellulare. Era mia madre in apprensione per il tremendo temporale abbattutosi nella notte dalle nostre parti. Almeno così aveva sentito dire alla tivù. Io le risposi che avevo avvertito giusto una pioggerellina. Quindi due erano le cose: o il megatemporale ci aveva appena sfiorati, oppure eravamo così stanchi da non sentire alcunché. Oppure il senso tragico di un genitore di un figlio in viaggio è inestinguibile.
Sistemammo le nostre cose e facemmo colazione in un bar dove sfruttammo il bagno. La cassiera, a vederci, ne rimase piuttosto affascina. Un tizio di trentanni, invece, ci indicò la via degli scavi archeologici i quali, pur essendo fuori città, non erano molto lontani.
Ci incamminammo a piedi tra bordi di strade statali, marciapiedi, ponti e banchine, cantando tutto ciò che ci passava per la testa. Dopo quaranta minuti arrivammo finalmente nei pressi del sito archeologico di Scolacium.
Quando Michele vide la facciata della cattedrale normanna spuntare tra gli alberi iniziò a guardarsi attorno alla ricerca di un punto dove scavalcare la recinzione. Eravamo dei viaggiatori squattrinati, nel vero senso della parola, e per tanto dovevamo risparmiare su tutto e quindi anche sui biglietti d’ingresso. Ma se da una parte le cose stavano proprio così, dall’altra Michele è uno di quelli che si trova più a suo agio a scavalcare anziché a camminare. Ad ogni modo ci bastarono pochi passi per scoprire che l’ingresso al parco archeologico era aperto e gratuito. E Michele, alias Indiana Jones de noialtri, dovette rassegnarsi ad un’entrata da comune turista.
Entrammo nel parco archeologico di Scolacium e ci portammo presso le rovine della cattedrale normanna. A guardarla fummo rapiti dalla sontuosità delle mura e dagli scorci interni. Prendemmo a discutere su come quella cattedrale poteva apparire ai suoi tempi e sui secoli a cui quei ruderi erano sopravvissuti. Capitava spesso di perderci in simili discorsi poiché sin dal primo giorno avevamo dato al nostro viaggio un nonsochè di epicità, un qualcosa che ci eleggeva ad impavidi avventurieri di una terra si, selvaggia, ma forte di un grande passato. Tutto ciò derivava da una parte dalle trenta visioni che avevamo fatto del film I Diari della Motocicletta, dall’altra dal bisogno di esorcizzare il peso degli zaini che gravavano sulle nostre spalle.
Intervallo.
Era la basilica di S. Maria Della Roccella, costruita sulle rovine dell’antica città Scolacium a partire dal XII secolo (e forse mai completata). In gran parte era stata costruita dai ruderi della città romana. Era caratterizzata da un’unica navata di 73 per 25 metri, illuminata da cinque finestre per lato e come copertura (ormai crollata) un tetto poggiato su capriate in legno. Riconoscibile lo stile normanno: semplice ma imponente. La guida diceva che nelle sue decorazioni, ormai perdute, vi dovevano essere anche linguaggi bizantini e islamici.
La discussione ci portò a cavallo delle epoche fino alla contemporaneità e alle sue problematiche. Ci credevamo davvero in quello che dicevamo come due Indiana Jones.
Entrammo nella cattedrale, facemmo le foto e come al solito, Michele Spiderman si arrampicò su per dei ruderi per farsi scattare una foto. Qualche minuto dopo alcuni impiegati ci invitarono ad uscire poiché era vietato addentrarsi tra le rovine. In questa occasione conoscemmo un archeologo che stava lavorando ad un sito a circa trenta metri dalla cattedrale. Ci prese subito in simpatia e ci portò al sito dove trovammo una decina di studenti universitari, schiavizzati a dovere. Questo simpatico archeologo, che chiameremo simpatico archeologo, appunto, ci accompagnò per il campo, tra le varie basi di mura che emergevano dagli scavi, spiegandoci, in linea di massima, come poteva essere strutturato l’edificio. Si trattava di una costruzione romano-bizantina (in alcuni tratti vi erano materiali preziosi, tipici degli edifici romani, ma in altri tratti vi erano materiali più scadenti, tipici dei bizantini).
Sistemammo le nostre cose e facemmo colazione in un bar dove sfruttammo il bagno. La cassiera, a vederci, ne rimase piuttosto affascina. Un tizio di trentanni, invece, ci indicò la via degli scavi archeologici i quali, pur essendo fuori città, non erano molto lontani.
Ci incamminammo a piedi tra bordi di strade statali, marciapiedi, ponti e banchine, cantando tutto ciò che ci passava per la testa. Dopo quaranta minuti arrivammo finalmente nei pressi del sito archeologico di Scolacium.
Quando Michele vide la facciata della cattedrale normanna spuntare tra gli alberi iniziò a guardarsi attorno alla ricerca di un punto dove scavalcare la recinzione. Eravamo dei viaggiatori squattrinati, nel vero senso della parola, e per tanto dovevamo risparmiare su tutto e quindi anche sui biglietti d’ingresso. Ma se da una parte le cose stavano proprio così, dall’altra Michele è uno di quelli che si trova più a suo agio a scavalcare anziché a camminare. Ad ogni modo ci bastarono pochi passi per scoprire che l’ingresso al parco archeologico era aperto e gratuito. E Michele, alias Indiana Jones de noialtri, dovette rassegnarsi ad un’entrata da comune turista.
Entrammo nel parco archeologico di Scolacium e ci portammo presso le rovine della cattedrale normanna. A guardarla fummo rapiti dalla sontuosità delle mura e dagli scorci interni. Prendemmo a discutere su come quella cattedrale poteva apparire ai suoi tempi e sui secoli a cui quei ruderi erano sopravvissuti. Capitava spesso di perderci in simili discorsi poiché sin dal primo giorno avevamo dato al nostro viaggio un nonsochè di epicità, un qualcosa che ci eleggeva ad impavidi avventurieri di una terra si, selvaggia, ma forte di un grande passato. Tutto ciò derivava da una parte dalle trenta visioni che avevamo fatto del film I Diari della Motocicletta, dall’altra dal bisogno di esorcizzare il peso degli zaini che gravavano sulle nostre spalle.
Intervallo.
Era la basilica di S. Maria Della Roccella, costruita sulle rovine dell’antica città Scolacium a partire dal XII secolo (e forse mai completata). In gran parte era stata costruita dai ruderi della città romana. Era caratterizzata da un’unica navata di 73 per 25 metri, illuminata da cinque finestre per lato e come copertura (ormai crollata) un tetto poggiato su capriate in legno. Riconoscibile lo stile normanno: semplice ma imponente. La guida diceva che nelle sue decorazioni, ormai perdute, vi dovevano essere anche linguaggi bizantini e islamici.
La discussione ci portò a cavallo delle epoche fino alla contemporaneità e alle sue problematiche. Ci credevamo davvero in quello che dicevamo come due Indiana Jones.
Entrammo nella cattedrale, facemmo le foto e come al solito, Michele Spiderman si arrampicò su per dei ruderi per farsi scattare una foto. Qualche minuto dopo alcuni impiegati ci invitarono ad uscire poiché era vietato addentrarsi tra le rovine. In questa occasione conoscemmo un archeologo che stava lavorando ad un sito a circa trenta metri dalla cattedrale. Ci prese subito in simpatia e ci portò al sito dove trovammo una decina di studenti universitari, schiavizzati a dovere. Questo simpatico archeologo, che chiameremo simpatico archeologo, appunto, ci accompagnò per il campo, tra le varie basi di mura che emergevano dagli scavi, spiegandoci, in linea di massima, come poteva essere strutturato l’edificio. Si trattava di una costruzione romano-bizantina (in alcuni tratti vi erano materiali preziosi, tipici degli edifici romani, ma in altri tratti vi erano materiali più scadenti, tipici dei bizantini).
Riprendemmo il cammino fino a ritrovarci davanti al foro romano. Si trattava di una piazza pavimentata con grandi mattoni sulla quale sorgevano i resti del Capitolium (il più importante monumento religioso della colonia di Scolacium), del Decumanus maximus (la strada più importante), della Basilica (edificio pubblico con funzioni amministrative e giuridiche), della Curia (sede del senato locale) e del Caesareum (edificio relativo al culto imperiale). Per chi serbava una certa curiosità per l’archeologia e le civiltà del passato tutto quel parco poteva apparire come un sogno. Cosa ci faceva una cattedrale normanna, accanto ad un foro romano e ad un edificio romano-bizantino? In realtà era anche questo a conferire una certa magia al nostro viaggio. Insomma, era il fatto di camminare in una terra dove era possibile trovare cenni di civiltà culturalmente e geograficamente molto distanti. E tutto ciò, per due menti malate di epica e avventura, era il massimo.
Raggiungemmo il teatro romano. Il teatro era una delle strutture che si era meglio conservato. Ben visibili erano la cavea (gradinata), l’orchestra (la zona del coro) e i tribunalia (per le persone di alto rango). Inoltre erano ben visibili i resti dei tre ingressi: hospitalia, valvae regiae e hospitalia. Secondo la guida fornitoci, se a qualcuno gliene può fregare qualcosa, il teatro fu costruito tra il I e il II secolo d. C.
Ci spostammo verso la necropoli bizantina. Per raggiungerla, tanto per cambiare, avanzammo per una salita così ripida che, con il peso dei borsoni, fummo lì lì per fare un capitombolo all’indietro. La necropoli infatti si trovava sul luogo più alto del parco archeologico, una collina che offriva un panorama in cui le rovine, sparse per la campagna, seguivano come costruzioni di un presepe improbabile fino al mare, limpido, piatto e scintillante sotto i raggi del sole. Decisi di donare al panorama uno scatto. La verità è che dovevamo fare economia anche sulle fotografie e questo ci induceva a fare una dura cernita delle cose da fotografare. O meglio, questo in teoria, perché quando si viaggia è inevitabile fare le cosiddette foto ad cazzum. Con o senza digitale.
Dopo un’ultima occhiata data al paesaggio riprendemmo a camminare. Passammo su un fazzoletto di terra cosparso di sassi, che scoprimmo essere un anfiteatro greco, e continuammo fino a raggiungere una fontana. Bevemmo, ci sedemmo su un gradino all’ombra e restammo lì, in silenzio, fino a quando Michele ebbe un’idea delle sue. Farci la barba a vicenda.
Tirò fuori il kit che avevamo comprato prima di partire. Gli chiesi se era sicuro perché non avevo intenzione di ritirarmi con qualche sfregio, ma era anche vero che le sue idee erano così folli da non poterci rinunciare. Spalmò la schiuma sul mio viso e iniziò ad armeggiare col rasoio. Dopo un primo tocco Michele constatò, con mia grande apprensione, che la mia barba era ben più dura della sua e che, di conseguenza, la sua mano era abituata ad una barba molto più morbida. Ma eravamo in una di quelle situazioni in cui, per qualche legge dell’universo, o per qualche forma di masochismo insito nella nostra natura, non potevamo più tornare indietro. Continuò a ridere come un folle torturatore per tutto il tempo, compiaciuto dopo ogni rasata di non aver fatto danni. Poi lui finì, io mi specchiai e il riflesso mi restituì un tizio con le guance rosse, la gola segnata da raschi qui e là, a dorso nudo e una capigliatura intrisa di sudore. Praticamente un reduce di guerra.
Si fece tardi e Michele mi suggerì di fare veloce. “Tanto la mia barba è abbastanza morbida” . Andai spedito.
Ritrovammo il simpatico archeologo e questi ci indicò un’uscita secondaria. Gli chiedemmo se fosse una buona idea scendere verso sud facendo autostop. “In questi periodi ci sono molte auto che scendono” ci disse senza esitare “se fate autostop qualcuno sicuramente si fermerà”. Come si suol dire: le ultime parole famose.
Circa 2500 anni fa, in quello stesso posto in cui ci eravamo fatti la barba, sorgeva la città greca di Skylletion, probabilmente fondata da Crotone in funzione di avamposto militare con la potente Locri. Ed è proprio qui, come direbbe Piero Angela, che i romani fondarono la Colonia Minervia Scolacium, dedicata alla dea Minerva. Tra il 96 e il 98 d. C. l’imperatore Nerva ne propose la ricolonizzazione facendo circolare tanto denaro pubblico. Di qui in poi la città si chiamò Minervia Nervia Augusta Scolacium, per gli amici Scolacium, e divenne un punto di riferimento per i rapporti commerciali con l’Africa e con l’Oriente.
Ci lasciammo la storia alle spalle e ci ritrovammo su una strada così stretta che era priva di una banchina. Camminare lungo quella via significava a destra strisciare contro il rialzo del terreno, a sinistra sentire le auto sfrecciare ad un metro dal braccio. Prendemmo subito a fare autostop nella speranza che qualche automobilista ci salvasse dal sole cuocente, ma, d’altro canto, la strada ci diceva già come sarebbero andate le cose. La carreggiata era così stretta che se fosse passato un buon samaritano non avrebbe avuto lo spazio dove fermarsi senza rappresentare un pericolo per chi veniva dietro.
Proseguimmo con la rassegnazione che lentamente si affacciava dentro di noi e nella speranza di vedere, da un momento all’altro, un segnale stradale che ci dicesse di essere vicini a Soverato, il paese successivo. Ma su quella strada cotta da sole non si doveva fare altro che armarsi di coraggio e continuare perché la strada da fare era tanta. Una trentina di chilometri ci avrebbero detto in seguito.
Camminammo con il braccio dritto e il pollice alzato, ma talvolta la strada si stringeva così tanto da dover ritirare il braccio onde evitare che qualcuno se lo portasse via. Così macinammo chilometri a piedi, con il sole che ci fece sudare anche l’anima. Era un tratto che non offriva scampo poiché né offriva svincoli per località intermedie, né ingresso per abitazioni private, né un filo d’ombra entro cui cercare riparo. Era tutto scoperto, offerto come sacrificio alla furia ardente del sole. Le auto passavano, gli automobilisti ci guardavano a volte stupiti, altre volte indignati, ma nessuno volle o poté fermarsi.
Il sole ci aveva rincitrulliti, oltre che ammutoliti. La stanchezza si era impossessata delle nostre gambe. Di Soverato nessuna indicazione, neanche un cartello stradale. Sembrava di stare in una terra di nessuno e quando ci si trovi in una terra di nessuno vien da chiedersi se si è nella direzione giusta o meno. Chissà. Ad ogni modo non c’era nessuno a cui chiedere informazioni. Poi, come un miraggio, vedemmo comparire un ipermercato. Di quanto in quanto gli ipermercati sono diventati delle oasi?
Entrammo per comprare un po’ di viveri: pane, melone e mele. Tornati all’ingresso guadagnammo un angolo di ombra e ci buttammo per terra come due barboni. Con ciò che avevamo acquistato e il solito tonno in scatola ci rifocillammo. Un pranzo niente male.
Riposammo nella nostra iper-oasi. Avremmo voluto aspettare un’ora meno calda ma avremmo perso inutilmente tempo rischiando, per altro, di fare la notte in quella terra di nessuno. Allora caricammo gli zaini sulle spalle, indossammo i cappelli, unici scudi contro il sole, e riprendemmo il cammino. Qualche chilometro e giungemmo in un presidio di civiltà, un agglomerato di palazzine che nessuno seppe definire. Entrammo nell’unico bar che vedemmo per chiedere informazioni sulla strada che ancora ci aspettava e, perché no, su eventuali pullman. Due ragazze sulla trentina, un po’ sulle loro, si proposero di salvarci con un passaggio in direzione Soverato. Noi lo accettammo con tanto tanto piacere.
Prima di entrare in macchina le due ragazze ci consigliarono di bere una bevanda tipica calabrese che ci avrebbe rimesso su: latte di mandorla. Non ne avevo mai sentito parlare ma dopo il primo sorso la mandai giù in un solo colpo. Mi sembrò di aver scoperto l’elisir dell’eterna giovinezza e ben presto sarebbe diventata per me quello che per Braccio di Ferro erano gli spinaci, giusto per intenderci.
Michele invece la battezzò come orzata dopo il primo sorso e la lasciò. Mandai giù anche il suo bicchiere per poi seguire le ragazze e Michele nella uno bianca.
Dopo tre ore sotto il sole, oltre venti chilometri di cammino, ci ritrovammo in rotta verso Soverato, a bordo di una quattro ruote guidata da due sirene. Eravamo stanchi si, ma sempre più eroi alla conquista della Magna Grecia.

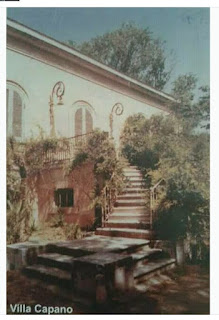


Commenti
Posta un commento